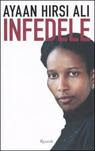Nathan Zuckerman (protagonista di altri romanzi di Roth e suo alter ego letterario), scrittore settantenne, cui la vita ha lasciato solo ricordi, reincontra l'idolo della sua adolescenza: Seymor Levov, detto 'lo Svedese' per il fisico alto e biondo, il migliore atleta del loro liceo, giocatore di basket, football e baseball, l'idolo di un intero quartiere. Questa è la sua storia.
'Pastorale' designa un poema di ambientazione agreste, dove la vita bucolica viene per lo più presentata in chiave idilliaca. Questo è il contrario, il rovesciamento di una pastorale.
Lo svedese appartiene a una famiglia di immigrati ebrei (suo nonno non parlava nemmeno inglese) che, col sudore della fronte e il duro lavoro, è riuscita ad arricchirsi nel settore dell'industria guantaria. Lo svedese è sempre stato un ragazzo modello: ligio al dovere, marine provetto, abbandona una promettente carriera sportiva per entrare nella fabbrica paterna e, come suo padre, ama il suo lavoro, è gentile coi propri operai e si dedica con solerzia all'incremento del patrimonio familiare. Lo svedese è esattamente quello che sembra: un uomo tranquillo e tollerante, preoccupato di non offendere mai nessuno, un'anima semplice che sogna una casa di pietra nel verde con una moglie in cucina e una figlia sull'altalena.
E i suoi sogni lo Svedese li avvera: perchè non dovrebbe? Lo Svedese è perfetto (o almeno così se lo immagina Nathan Zuckerman), lo Svedese è buono e gentile, lo Svedese è il sogno americano. Ma il sogno di Seymor Levov, il sogno che Seymor Levov è, si tramuta presto in una tragedia (se non in una farsa) a causa dell'amatissima figlia Merry - la sua famiglia si sgretola, le sue certezze controllano in una crisi soggettiva senza uscita che lo costringe a mettere in discussione il suo passato e la sua identità senza offrire alcuna prospettiva alternativa.
Pastorale americana di Philip Roth mi è piaciuto - la scrittura è intensa, anche se a tratti un pò faticosa, i personaggi e le situazioni sono credibili e ben delineati - eppure non mi ha entusiasmato. Spesso, si sa, i libri ci coinvolgono di più o di meno a seconda del periodo in cui li leggiamo, a seconda della nostra contingente situazione emotiva. Credo, però, che ci siano anche delle ragioni per il mio mancato entusiasmo.
Innanzitutto questo romanzo non mi è parso affatto, come invece ha scritto qualcuno, un affresco della società americana degli anni '60-'70. E' vero che la figura dello Svedese e, ancor più, quella meno stereotipata di suo padre incarnano una serie di valori e aspirazioni tipici di una certa società americana, ma è vero anche che le vicende politiche di quegli anni non giocano alcun ruolo effettivo nella dinamica del romanzo. In particolare, allo Svedese del Vietnam non importa nulla, così come non gli importa nulla di tutto ciò che non lo riguarda personalmente e il suo crollo è causato da un fatto privato, del tutto accidentale: sua figlia è pazza - come egli stesso alla fine dovrà ammettere, rinunciando definitivamente a trovare un senso nell'intera vicenda.
In Vietnam l'America ha perso la sua innocenza in un senso ben più radicale di quello di veder trasformare un pugno di ragazzine di buona famiglia in terroriste fanatiche. Ma questo è l'unico aspetto che emerge dal romanzo di Roth - un romanzo in cui le uniche persone interessate alla politica vengono presentate o come psicotiche sanguinarie (vedi Merry e Rita Cohen) o come pseudo-intellettuali sadiche (vedi Marcia Umanoff).
Cosa c'era di male nel sogno dello Svedese? Ci chiede Roth-Zuckerman. Nulla, ma è un sogno solipsistico, oltre che individualista, un sogno che può anche andar bene per chi, come Zuckerman o lo Svedese, decida di isolarsi dal resto del mondo, ma che è destinato a naufragare nel momento in cui lo scontro con la società diventi inevitabile. E soprattutto è un sogno che non mi piacerebbe sognare.
Su Roth cfr. anche la recensione al bellissimo Everyman